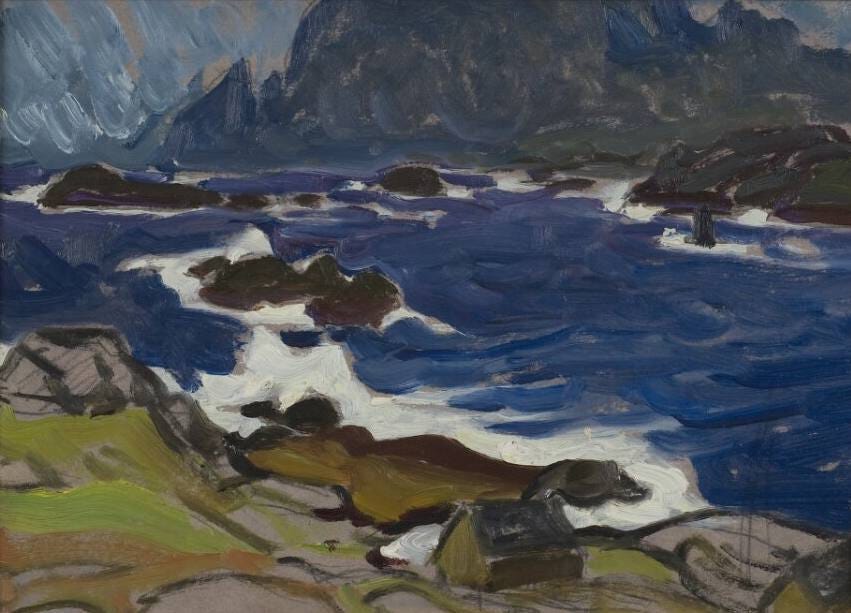
Ho iniziato questa newsletter negli ultimi giorni del 2024. Giorni di quiete, che ho trascorso in modalità risparmio energetico occupata in letture e scavi archeologici interiori.
Sembravo il tenente Colombo quando è vicino alla soluzione di un caso: la mano sulla fronte (senza sigaro però) corrugata nello sforzo di partorire un’intuizione (o di partorire me stessa, di nuovo, ogni anno, a capodanno1).
Gennaio è un ponte tra le riflessioni dei mesi precedenti e le azioni di quelli successivi, un tempo liminale che uso per raccogliere i pensieri (e abituarmi a scrivere la data dell’anno corrente). Buoni propositi, nuovi inizi? No, grazie.
Aver compreso che c’è una relazione tra il mio corpo e la ciclicità della natura è stata una rivelazione. Aver accettato l’esistenza di un calendario interno che non segue i ritmi imposti dalla società del fare sa di rivoluzione.
Osservo la fluttuazione delle mie energie fisiche e mentali nel corso dell’anno come fossero titoli di borsa, seguo con attenzione la vita silenziosa del nostro giardino2, celebro solstizi ed equinozi e ascolto gli alberi parlare con il vento. Sto recuperando la capacità di vedere e molte altre cose che avevo perduto. Sto reimparando a stare al mondo.
Scintille
Il mondo è bloccato in un ciclo di vittime e carnefici. Vittime che diventano carnefici. Carnefici vittimizzati dai loro stessi crimini. Io vorrei sfidare tutto questo uscendo dal ciclo e diventando un essere umano libero.
Queste parole sono di Metko (visto che l’introduzione di oggi è dedicata ai cicli, mi sembravano appropriate), una delle tante persone incontrate da Kapka Kassabova in Bulgaria durante la sua permanenza nella valle del fiume Mesta3, esperienza raccontata in Elisir. Nella valle alla fine del tempo (Crocetti Editore, 2023).
Il territorio esplorato dall’autrice è un’area geografica molto ricca dal punto di vista ecologico, circondata com’è da tre sistemi montuosi (i Rodopi, il Pirin e il Rila) e non intaccata dall’industrializzazione. Ha qualcosa di primordiale, sacro, segreto.
Questa valle è sospesa in una straordinaria rete composta da acqua, fuoco e aria, e dentro la rete c’è un cammino che dovevo trovare. C’è qualcosa di dimenticato che io dovevo ricordare. Mi aveva chiamato ed ero venuta. Se si eccettua la lingua, ero una forestiera. Non conoscevo un’anima, e questa volta non portavo con me un dolore personale, ma quello del mio fiume e dei miei boschi scozzesi.
È inoltre la terra ancestrale dei Pomacchi, i musulmani slavi, che ci vivono insieme a minoranze cristiane e rom. Cosa è rimasto di questo popolo e delle sue conoscenze erboristiche e cosa possiamo apprendere riguardo alla malattia e alla guarigione, si chiede Kapka.
La raccolta e il commercio delle piante qui ha una storia millenaria. Il comunismo creò una fiorente “catena di produzione della natura” che occupava l’intera comunità e riempiva solo le tasche di chi stava al vertice. Quelli furono pure gli anni della distruzione delle foreste native e del terrore istituzionalizzato nei confronti dei Pomacchi.
Oggi, nella regione, le aziende che commerciano piante all’ingrosso sono solo due e sopravvivono grazie al lavoro di persone, per lo più rom, che in cambio di pochi spiccioli passano giornate intere a raccogliere piante e funghi.
Con la curiosità, l’empatia e la sensibilità che la contraddistinguono, Kapka Kassabova si addentra in un microcosmo di storie e personaggi che la sua penna rende indimenticabili. L’enciclopedico Metko, che ho citato all’inizio, è uno di loro. Ma le mie preferite sono le babi4, che curano le afflizioni dell’anima e del corpo.
Elisir è il penultimo libro di una tetralogia sui Balcani iniziata nel 2017 con Border. A journey to the edge of Europe5 e conclusa nel 2024 con Anima. A wild pastoral6. È un concentrato di cose che mi fanno scintillare il cervello, anche perché abbraccia settori di competenza diversa. È stata l’ultima lettura del 2024 e una delle più belle fatte lo scorso anno.
A proposito di Balcani, sapevi che le erbe spontanee, i funghi e perfino i licheni furono usati per la sussistenza alimentare a Sarajevo durante l’assedio della città (1992-1996), in enclavi isolate della Bosnia orientale e nei luoghi dove non arrivavano gli aiuti umanitari? Io l’ho scoperto grazie a Fungotropia, una newsletter a base di funghi, storie e connessioni fungine che ti straconsiglio.
L’avrò guardato almeno una decina di volte tanto mi è piaciuto. Mi riferisco a un breve documentario del The New Yorker sulla tradizione bulgara dei Kukeri. Puoi vederlo qui.
I Kukeri sono persone mascherate che danzano per strada con campane appese alla cintola per scacciare gli spiriti maligni e invocare la buona sorte. Le maschere, realizzate con piume, pelliccia e altri materiali, sono colorate, spesso grandi, a volte mostruose.
Il rito dei Kukeri si tiene tra gennaio e marzo in tutto il Paese, specie nei villaggi e nelle piccole città. Alcuni festival, come quello di Surva a Pernik, hanno ricevuto il riconoscimento dell’Unesco.
Nel documentario di Killian Lassablière, i Kukeri indossano maschere che li fanno apparire enormi, metà animali metà demoni. La tradizione, la cui origine è incerta, viene tramandata di generazione in generazione da tempo immemorabile.
Erbario
Sono gli unici che mi capiscono. E io sono la sola che li capisce. Quattro alberi striminziti dal collo esile e i gomiti puntuti proprio come i miei. Quattro alberi che qui non c’entrano niente eppure eccoli qua. Quattro gracili scuse piantate qui dal comune. Dalla nostra stanza li sentiamo stormire, ma Nenny continua a dormire beata e non apprezza questo genere di cose.
La loro forza è segreta. Sottoterra estendono radici feroci. Crescono sia in altezza sia in profondità, afferrano la terra tra le loro dita pelose e mordono il cielo con denti violenti e la loro rabbia non cessa mai. È così che resistono.
La citazione è tratta da La casa di Mango Street di Sandra Cisneros (La Nuova Frontiera, 2007) e le “quattro gracili scuse” sono degli olmi piantati dal comune davanti alla casa dove Esperanza Cordero, la protagonista preadolescente del libro, va ad abitare con la famiglia.
A Chicago, nel barrio di chicanos dove si trasferisce, Esperanza si sente un’estranea. E gli esili olmi che vede dalla finestra della sua camera un po’ le somigliano. Circondati da asfalto e mattoni hanno “radici feroci”, “mordono il cielo con denti violenti e la loro rabbia non cessa mai”.
L’olmo (Ulmus L.) è un albero deciduo appartenente alla famiglia delle Olmacee. Mette prima i fiori e poi le foglie7. I frutti (samare) iniziano a formarsi già prima delle foglie e sono commestibili (andrebbero consumati nella fase in cui sono ancora verdi e la parte al centro non si è scurita). La loro forma ricorda un’ala. Quando si seccano si staccano dal ramo e volano via, portando il seme lontano dalla pianta madre.
Nella mitologia greca e romana l’olmo era associato alle divinità del sonno e dei sogni. Ed è proprio mentre dorme che i quattro olmi esortano Esperanza a resistere in un luogo che non le appartiene, in una vita che vorrebbe diversa.
Nell’Eneide di Virgilio8 un grande olmo sta nel mezzo del vestibolo dell’Orco, un luogo popolato da creature mostruose e sciagure umane. Nella mitologia nordica la prima donna, Embla, fu creata da un olmo (il primo uomo, Ask, da un frassino).
Nel corso del tempo l’olmo è diventato simbolo di amore coniugale, amicizia e forza (ha radici robuste ed è longevo) e il legame con il mondo onirico e l’aldilà ha fatto sì che gli venisse attribuito un potere oracolare.
Sul blog…
c’è il mio breve brevissimo resoconto bookolico del 2024.
Sono nata il primo di gennaio. Io non volevo nascere a Capodanno, ma visto che tardavo, a una certa mi hanno tirata fuori (senza la mia autorizzazione, sia messo agli atti).
È un giardino che condividiamo con gli altri inquilini del palazzo e ne sono innamorata.
Il Mesta nasce sui Monti Rila e sfocia nel mar Egeo, attraversando quindi Bulgaria e Grecia. In greco è chiamato Nestos.
Sono donne anziane che mettono le proprie conoscenze erboristiche al servizio della comunità in cui vivono. Creano preparati per curare problemi di salute, compiono rituali per questo e per quello e conoscono metodi per diagnosticare la presenza di un maleficio.
Pubblicato da EDT con il titolo Confine. Viaggio al termine dell’Europa e tradotto da Anna Lovisolo.
Pubblicato da Crocetti Editore con il titolo Anima. Una pastorale selvaggia e tradotto da Anna Lovisolo.
Viene quindi definita isteranta.
Nel libro sesto, dove è narrata la discesa di Enea agli inferi guidato dalla Sibilla Cumana.





E mentre scopro dei Pomacchi e dei Kukeri, mi scopro citata in questo numero pieno di Balcani e di storie di piante, erbe, danze e maschere. Che onore, davvero. 🍄🟫